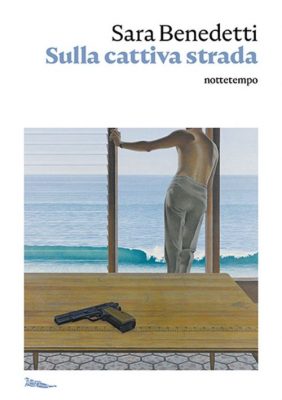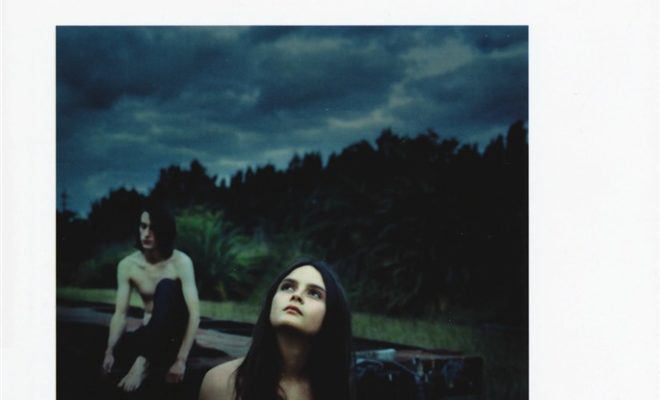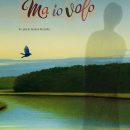“Malattia come metafora” e “L’AIDS e le sue metafore” di Susan Sontag

“Malattia come metafora” e “L’AIDS e le sue metafore” di Susan Sontag sono due scritti usciti rispettivamente per la prima volta nel 1978 (quando il cancro entrò nella vita dell’autrice stessa) e nel 1989, che possiamo oggi risfogliare grazie alla casa editrice nottetempo (2021, pp. 234, euro 18, traduzione di Paolo Dilonardo).
È davvero così necessario attribuire un significato culturale o dare una spiegazione a una malattia? È davvero opportuno cercare in ogni cosa una morale? Si comincia parlando di cancro e di tubercolosi, due malattie – del passato una e del presente l’altra – “misteriose per definizione”. Si comincia allontanandosi dal concetto di metafora, perché il modo più sano per essere malati è appunto la “resistenza al pensiero metaforico”, per creare una distanza da quell’alone di mistero che circonda le malattie e che quasi serve a renderle contagiose pur solo parlandone. Ed ecco quindi la funzione e il potere delle parole consolidato nelle “etichette”, che di sicuro non vanno ad alleggerire l’effetto che il nome di questi mali ha sui pazienti in primis, ma anche su chi li circonda. È già la stessa parola cancro pronunciata davanti al diretto interessato a costituire una sentenza di morte psicologica ancor prima che fisica e che porta a nascondere o addirittura a negare la malattia. A salvarci da questo modus vivendi ci pensa bene – e già pensato anche in passato – la letteratura, e qui Susan Sontag analizza nei dettagli ruoli, stati d’animo di grandi personaggi dei libri o i loro stessi autori, lì dove le pene d’amore diventano deterioranti per il corpo stesso e dove la tbc, ad esempio, arrivò addirittura a rappresentare “un nuovo modello di bellezza aristocratica”, donando una sorta di fascino malinconico alla malattia.
Evitare che la malattia diventi una colpa sia a livello personale e sia a livello sociale, su questo ragiona la Sontag, soprattutto se si parla di AIDS, la condizione delle colpe per eccellenza, la più famosa e imaginifica delle contaminazioni, legata sin dai primi anni ’80 all’omosessualità e alla tossicodipendenza, quindi a un atto “intenzionale e, dunque, più riprovevole”. È proprio questa veste immaginaria a essere più forte della malattia stessa e a declassare il malato all’interno della vita sociale. Ed è ciò che Susan Sontag vuole spiegarci, allontanandoci dai retaggi culturali, politici e sociali, che è la metafora stessa a schiacciare l’individuo, prima ancora che la vera e propria malattia.
Marianna Zito