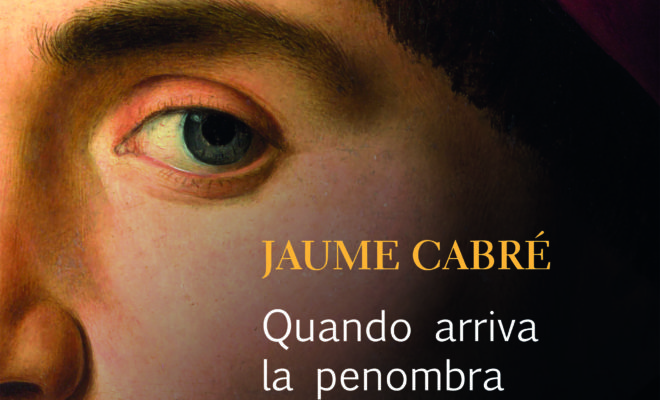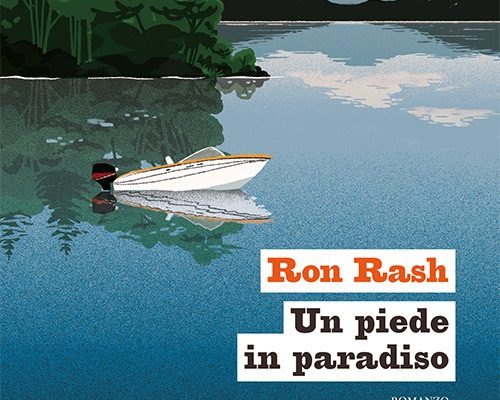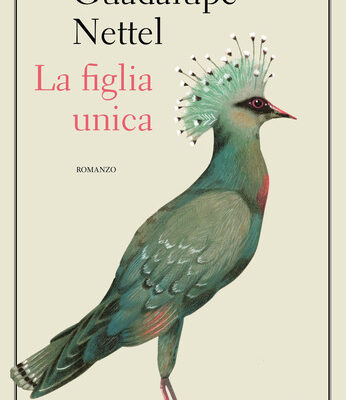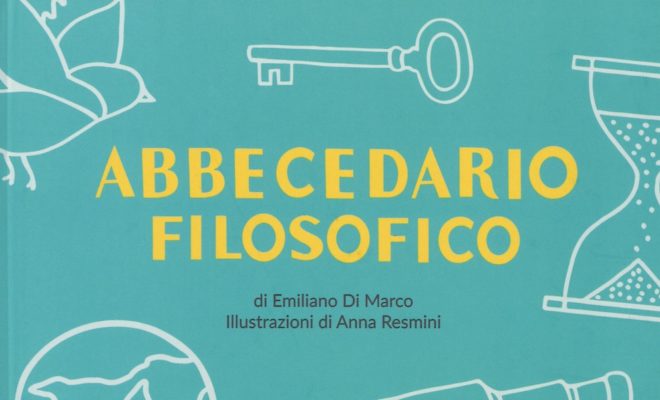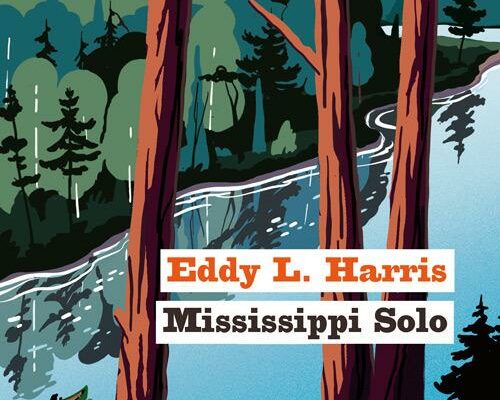“Il fiume senza sponde”- L’Argentina di Saer

Quanta verità e bellezza negli scritti di Juan José Saer. “Il fiume senza sponde” (La Nuova Frontiera, 2019, pp. 254, euro 18, traduzione dallo spagnolo di Gina Maneri con gli allievi della scuola di specializzazione in traduzione editoriale Tutteuropa di Torino), uscito per la prima volta nel 1981, è un “Trattato immaginario”, l’unico lavoro che Saer scrisse su commissione e che vede come protagonista il vasto e inabbordabile Río de la Plata, il corso d’acqua che prende vita dalla confluenza dei fiumi Uruguay e Paranà. Un corso d’acqua che, nel 1516, aveva intorno a sé solo desolazione, e che ha visto il riflesso di eroi, saggi e tiranni; mentre ora, sulle sue sponde, si affacciano Buenos Aires e Montevideo. Un “triangolo di terra di un verde azzurrino, stretto fra i due nastri immobili quasi incolori, giaceva sotto di noi, in mezzo a un’immensa distesa piatta dello stesso verde azzurrino, immobile, immemore e vuota…”. Per questo lavoro di stesura, al nostro autore non restava quindi che “ritornare sui luoghi dei fatti”, rispolverare il passato e cercare nuove informazioni appartenenti al presente. Una riflessione sull’orrore e la volgarità legati ai “luoghi comuni concepiti dalla cultura dello svago” e sulle medesime sensazioni o pensieri che si ripropongono nella vita in determinati momenti, sempre gli stessi. E, quando ci si lascia andare, tutto si ferma, lasciando spazio ai dolci pensieri del passato. Come nel viaggio, sempre quello, da Parigi a Buenos Aires del 1989, passando per l’alba dalle sfumature rosa di Rio de Janeiro.
“Era il luogo da cui venivo: in esso, morte e piacere mi appartenevano in modo inevitabile”.
Dopo quindici anni di assenza l’autore, osservando il delta dall’alto, si abbandona a un sentimento di piacere malinconico guardando quei luoghi “dove si alternavano commedia e tragedia” e teatro di quelle situazioni politiche, economiche e sociali che, poco meno di cinquanta anni fa, hanno cambiato l’Argentina, arrivando a capovolgere la natura delle cose, facendo anche in modo che fossero i padri a seppellire per primi i propri figli. In questi suoi rientri a casa, Saer – come di consueto – si imbatte nelle stesse avenide alberate, negli stessi luoghi e paesaggi della città di Buenos Aires, costruita a scacchiera, dove il resto degli elementi urbani è caos: l’incongruenza è la norma già a partire dalla costruzione delle case, che propongono un’architettura anarchica e discordante, dove l’unico rigore restano gli ampi rettilinei delle strade; fino ai sentieri, alle vegetazioni fitte e l’acqua fangosa dell’estuario, dove il clima mite lascia facilmente posto a frequenti e spaventose tempeste, anche nel giro della stessa giornata o dello stesso pomeriggio.
“E se l’insieme è privo di interesse, a essere generosi, il dettaglio sorprende, incanta e meraviglia a ogni passo”.
Lasciandosi alle spalle la città, si va quindi verso la meta, incontrando gli strati di colore rosa, giallo e lilla del lapacho, dell’acacia gialla e della jacaranda. E qui si mescolano letteratura, poesia e persino la dittatura che, tra il 1975 e il 1983, occultava i propri crimini con cortine di questi fiori. Saer mostra come tutti gli elementi coincidono, si baciano e si distruggono, creando bellezza e atrocità allo stesso tempo. Si arriva infine al fiume, dove il tempo storico passato dell’Argentina si connette all’era tecnologica, che vede al suo fianco un aeroporto. Un fiume dalla superficie liscia, senza increspature, vuoto e incolore: un paesaggio di acqua e cielo in un’immobilità spiazzante. E alzando gli occhi si nota la mancanza immediata di un elemento di completezza di tutti i fiumi, la sponda opposta. Ci troviamo di fronte a un fiume senza forma che nel 1516, dal sapore delle sue acque, Juan Díaz de Solís denominò Mar Dulce; corso d’acqua che disorientò persino i suoi primi esploratori, non sempre riservando loro un così dolce destino.
Tanti frammenti per una visione sfaccettata e magnifica. Uno sguardo oggettivo che diventa soggettivo quando subentrano i ricordi dell’infanzia, con cui Saer crea legami anche con gli altri suoi scritti, mentre va alla ricerca dell’identità indefinita di queste terre e delle persone che le abitarono, fino a ricostruire la toponomastica e le tradizioni dell’intera nazione. Una terra disabitata e di passaggio, dove c’erano solo fauna umida e insetti nocivi a oscurare l’aria e da cui persino gli indios si tenevano alla larga, finché non arrivarono gli spagnoli a disseminare nel deserto della pampa i primi cavalli che, moltiplicandosi, diventarono l’essenza di questi luoghi; animali di cui indios e gauchos non fecero più a meno: “il cavallo era per gli indios un’appendice della loro persona”. Ed è grazie al bestiame, bovino ed equino, che in questo deserto nacque la civiltà ed è grazie a loro che Saer ritrova, dopo anni, il senso di appartenenza: muggiti, nitriti e latrati sono le voci familiari nello spazio sconfinato della pampa.
Non troveremo nulla di fittizio, ma attraverseremo quattro capitoli che si susseguiranno sotto i nostri occhi come le stagioni australi, come le fasi della di questi popoli e di questa terra, l’Argentina.
Marianna Zito