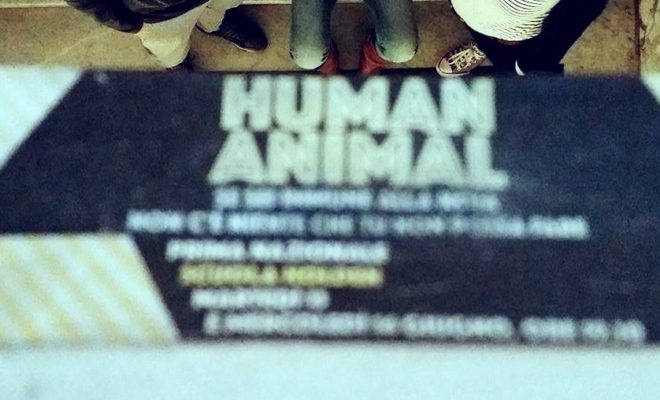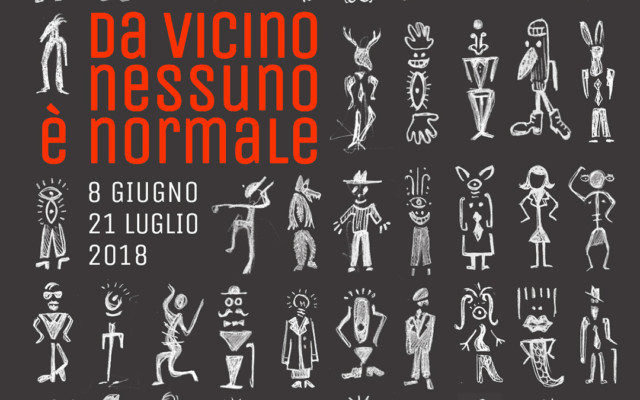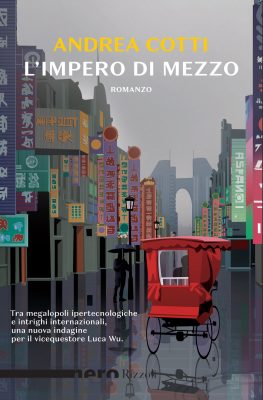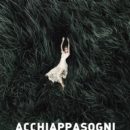“David Foster Wallace. La cometa che passa rasoterra” di Emiliano Ventura

Dopo il suo suicidio, il geniale scrittore americano David Foster Wallace è diventato ancora più conosciuto e famoso. A dieci anni dalla sua morte, sono state numerose le pubblicazioni dei sui libri e la pervasività iconica dello “scrittore con la bandana”. Sebbene negli USA, già in vita, fosse stato abbondantemente premiato (tra cui il pregiato Lannan Literary Awards per il romanzo Infinite Jest, considerato all’unanimità come il suo capolavoro), nel nostro Paese Wallace ha conosciuto la popolarità con una differita di qualche anno, considerando anche la difficoltà di traduzione di un autore che, come ricorda una delle sue traduttrici italiane, Martina Testa, in una delle interviste in appendice, teneva molto all’esattezza delle parole, che aveva “l’ossessione dell’esattezza delle parole: evitare l’uso di un linguaggio approssimativo o banale era per lui un problema etico e metafisico”. L’arrivo differito di Wallace in Italia e la difficoltà di lettura delle sue opere sono un paio dei motivi per cui le pubblicazioni scientifiche e non, sono ancora molto scarse a livello di numero.
Partendo da questa considerazione, l’autore di questo libro, Emiliano Ventura, tenta di tracciare un sentiero di base per studi futuri. Ventura, ricercatore universitario, vuole dimostrarci quanto sia stato importante, per la generazione di studenti universitari degli anni Novanta, la scoperta di questo scrittore che riusciva a scrivere di logica modale e filosofia, Federer e serie tv. Proprio dagli spunti biografici parte l’analisi di questo saggio, che si concentra su alcuni testi in particolare e su alcuni punti, quali il significato di postmoderno e di metafisica, l’analisi della filosofia modale e le influenze del pensiero di Wittgenstein (il primo romanzo di Wallace, La scopa del sistema del 1987, risente volutamente, secondo lo stesso autore, delle opere di Wittgenstein e Derrida), l’analisi di Strade perdute, il film di David Lynch del 1997. Insomma, David Foster Wallace rientra appieno nella corrente postmodernista e del movimento avant-pop, che ha come riferimento proprio gli anni Novanta e che è caratterizzato dall’uso “di materiali eterogenei provenienti da pubblicità, musica, cinema e letteratura”. Ma sono il postmoderno e il metaromanzo che Emiliano Ventura sottolinea, rivelando la differenza tra la corrente americana e l’esperienza europea. In termini molto sintetici, mentre il postmoderno europeo ragiona sui testi e sulla forma della scrittura, quello americano è interessato alla metafiction. Ed è tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, che la metafiction usa diverse armi per attaccare la cultura dominate, moralista ed ipocrita: l’autoreferenzialità, l’ironia, il cinismo e il sarcasmo. Gli iniziatori sono John Barth e Donald Barthelme. Ma ecco che, principalmente la tv, si appropria della critica postmoderna e la fa sua, così che, specialmente l’ironia, si ritorce per divenire arma nichilista. Il nichilismo è ciò contro cui Wallace si scaglia nelle sue opere, rea di non creare quel linguaggio che accomuna e che invece distrugge senza costruire nulla. Emiliano Ventura ci guida in questo e altri concetti attraverso le analisi di Mario Perniola sul postmoderno, attraverso la lettura heideggeriana del romanzo Infinite jest fatta da Chiara Scarlato.
“David Foster Wallace. La cometa che passa rasoterra” (2019, pp. 208, euro 14) di Emiliano Ventura, edito dalla casa editrice romana Elemento 115, è una guida, una proposta di lettura, un omaggio a uno scrittore che, nella sua breve vita ha cercato di trovare le parole adatte per comunicare e capire l’essere umano. Tutta la sua opera “deve essere vista come il tentativo di uscire dagli aspetti più distruttivi, nichilistici appunto, della postmodernità”.
Giovanni Canadé