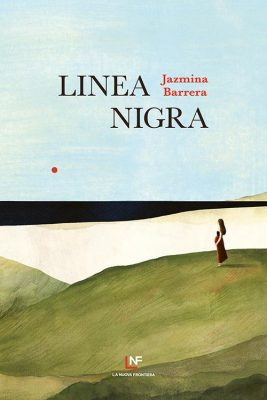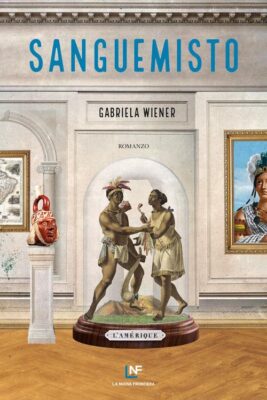“Il corpo in cui sono nata”: accettarsi, viversi

La nuova Frontiera ha di recente pubblicato “Il corpo in cui sono nata” (pp. 185, euro 16,90) della messicana Guadalupe Nettel, già uscito in Italia nel 2014.
Fermo restando che la bellezza di un libro è strettamente legata al periodo in cui e alla predisposizione d’animo con cui lo leggiamo, senza troppi dubbi il primo aggettivo che viene in mente per questo è meraviglioso.
“Yes, yes/ that’s what/ I wanted,/ I always wanted,/ I always wanted, /to return/ to the body/ where I was born (…) anch’io sognavo di accettare me stessa, anche se allora non sapevo con precisione qual era l’identità che avrei dovuto portare allo scoperto”.
La protagonista racconta alla propria psicanalista, in quello che di fatto è un lungo monologo, la sua infanzia segnata da un problema alla nascita: un neo bianco sulla cornea che l’ha costretta a portare per anni un grosso cerotto sull’occhio sinistro. Sviluppa così fin da piccolissima un senso di estraneità nei confronti del mondo che la circonda, accentuato e definito proprio dal rapporto col suo corpo. “Scarafaggio”, per via della postura sempre pronta a schivare il mondo, è il soprannome che le dà la madre e più volte la protagonista citerà non a caso Gregor Samsa (La metamorfosi di Kafka). Solo a un certo punto della vita scoprirà che lo scarafaggio è meno schifoso di quanto tutti pensino: ha origini nobili e una forza tale da resistere ai disastri nucleari. Al punto da meritarsi a pieno titolo di stare in mezzo alle farfalle (e la copertina del libro non è casuale, mai). Sullo sfondo, il Messico degli anni Settanta, la scuola Montessori, i figli degli esuli politici e due genitori che crescono i figli, e plasmano se stessi, con una sincerità e una modalità sperimentali, fin troppo. Ma poi, con gli anni Ottanta, tutto viene spazzato via: la famiglia si disgrega, il padre sparisce per guai giudiziari, la madre si trasferisce in Francia per proseguire gli studi lasciando la giovane e il fratello, con la nonna materna che dalle aperture genitoriali li riporta direttamente all’Ottocento. Troppo indietro per una bambina che già a sei anni scopre che il sesso può essere piacevole come un cioccolatino, o generare dolore quando imposto.
Quella che, analizzata nei fatti, potrebbe essere la descrizione di una vita abbastanza complessa, tra problemi alla vista, rimbalzi tra Francia e Messico, dinamiche familiari, complicanze adolescenziali varie ed eventuali, è in realtà la bellissima storia, in parte autobiografica, di una crescita fino all’accettazione di sé, colma di ironia, scritta da mani sapienti, da uno sguardo sul mondo aperto. Già in “La figlia unica”, e già avendo avuto il piacere di ascoltarla durante l’ultima edizione di “Più libri, più liberi” è chiaro che la Nettel ha un concetto di natura molto ampio che abbraccia ogni forma di vita e ogni forma di espressione/manifestazione/gestione di sé, in cui tutto è normale finché riguarda la nostra persona. Questo romanzo ne è l’ulteriore dimostrazione. La Nettel ha il grande dono di farci sentire giusti nel posto giusto.
“I comportamenti acquisiti durante l’infanzia ci accompagnano per sempre, e anche se a forza di volontà li teniamo a bada, acquattati in un luogo tenebroso della memoria, quando meno ce lo aspettiamo ci saltano in faccia come gatti inferociti (…) per me il presunto incanto che molta gente attribuisce all’infanzia è uno scherzo giocato dalla memoria. (…) i bambini vivono in un mondo dove la maggior parte delle situazioni in cui si trovano è imposta. Altri decidono per loro.”
La Nettel è a tratti esilarante nel raccontare il modo in cui subiamo i nostri genitori e la famiglia in generale, almeno fino a una certa età, i traumi che ci lasciano con le loro improvvisazioni e ne ridiamo e sappiamo addirittura coglierne il lato ironico perché tutto sommato, psicanalisi a parte, siamo sopravvissuti. Certo, a caro prezzo. Ci vuole tempo prima di abitare il proprio corpo, accettarsi in pieno. Prima di imparare a evitare il silenzio per paura di tradirsi, mostrarsi. Quel silenzio che, come il sale, solo in apparenza è leggero. Se lo si lascia inumidire diventa pesante come un’incudine.
“Il corpo in cui siamo nati non è lo stesso in cui lasciamo il mondo. Non mi riferisco soltanto alle cellule che mutano un’infinità di volte, ma ai suoi segni distintivi, ai tatuaggi e alle cicatrici che con la nostra personalità e le nostre convinzioni aggiungiamo via via, per tentativi, meglio che possiamo, senza guida né indicazioni.”
In mezzo a idee e situazioni che cambiano, la nostra persona è l’unico punto fermo, la forza da cui far partire tutto il resto, consolandoci “pensando che ogni oggettività è soggettiva”.
Laura Franchi