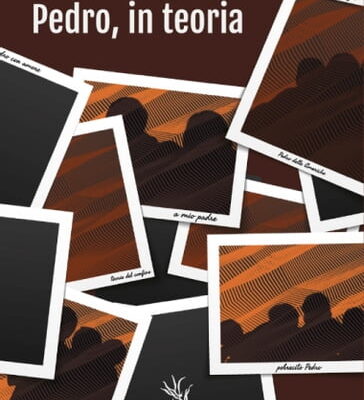“Fate fuori il vostro capo: licenziatevi!” – Il saggio di Vivian Abenshushan

Un libro contro il lavoro, più precisamente un saggio che si scaglia violentemente contro la macchina produttiva della nostra civiltà, può sembrare una provocazione fuori luogo in tempi di scarsa occupazione come i nostri. Pubblicato nel 2015, “Fate fuori il vostro capo: licenziatevi!” di Vivian Abenshushan (Eris Edizioni 2015, pp. 304, euro 18) possiede la carica esplosiva di un manifesto contro il lavoro, messo in pratica dalla stessa autrice.
Vivian Abenshushan è infatti una scrittrice messicana, ex capo redattrice di una rivista culturale che, prendendo coscienza delle ore che un lavoro malamente retribuito e perennemente presente toglie al resto della sua vita, decide di licenziarsi. “Molto presto mi sono resa conto che il lavoro è un purgatorio inutile, soprattutto se consiste nel vendere la tua anima all’industria culturale – industria spietata come qualunque altra che negli ultimi decenni ha adottato un abominevole sistema “leonino”: orari del XIX secolo, lavoratori sottopagati, ritardi nei pagamenti, nessun contratto né diritto a prestazioni sociali, nessuna garanzia”. L’autrice parla del Messico, ma nel nostro mondo di sfruttamento globalizzato, è come se parlasse anche di noi. Ecco, oltre all’originalità del tema frequentato (ma in appendice troviamo delle liste bibliografiche e non solo esplicative di ciò che è prodotto fino a oggi sull’argomento), pensiamo sia da sottolineare l’importanza di mettere sotto accusa un ambiente spesso sottoposto a una visione romantica, ma che nel mercato del lavoro non differisce dalla gestione di un’azienda qualunque. “Non lavorare mai”, era il proclama situazionista apparso sui muri di Parigi nel 1953, “che aveva lanciato una critica radicale al carattere insaziabile dell’economia di mercato all’interno della quale la produttività non è altro che schiavitù mascherata da fugace fortuna”. La stessa scritta, Vivian la ritrova sui muri di Buenos Aires, durante il viaggio che diede all’autrice la spinta per abbandonare il suo lavoro. Il libro è dunque un attacco al lavoro, ma più precisamente all’esigenza della produttività che assoggetta e cambia il nostro corpo, le nostre abitudini; che in nome del profitto, del guadagno poi mai adeguato alla fatica, ci ruba tutto il tempo necessario a vivere, a essere “umani”. “Se il lavoro ti fa star male, lascia il lavoro”, dice un proverbio cinese. E la sfida è quella di riprendersi il proprio tempo laddove una nuova morale, dice l’autrice, la morale del denaro, ha stabilito che perdere tempo è peccato.
È la storia dell’uomo che inizia con questa maledizione, e nel capitolo “Genealogia dell’ozioso”, Abenshushan ci guida attraverso la storia archetipica dei Caino e Abele, i due fratelli del mito biblico, visti in contrapposizione tra l’Homo Faber Caino (la cui radice del nome viene dall’arabo gain, fabbro), l’uomo che costruisce strumenti ed esercita la trasformazione della materia ai propri fini produttivi, che dunque vuole ottenere, prendere, governare la Terra, e Abele, il nomade, colui che non è legato a nessun luogo, che ha come fonte di sussistenza se stesso e la spontaneità della Terra; Abele (dalla radice hebel: fiato, soffio, niente), l’Homo Ludens, il pastore che ha più tempo per oziare, pensare, osservare. Dio scelse Abele e punì Caino, “proprio perché durante il suo sacrificio aveva agito per mero senso del dovere invece di farlo con generosità, spinto da amore puro, come invece aveva fatto Abele”. Vivian Abenshushan prosegue ancora il suo “controsaggio” con appassionante vitalità, accusando l’addomesticabilità dell’ambiente culturale e della letteratura in particolare.
La lettura di questo è coinvolgente, non accademica ma non superficiale. Le argomentazioni sono avvalorate da molte citazioni che portano, alla fine del volume, a chiederci tutti noi se quello per cui lavoriamo, se il tempo che dedichiamo al lavoro sia il tempo che possiamo permetterci di ipotecare per un futuro che, nel migliore dei casi, ci metterà nella nostra casella, in attesa della nostra dipartita.
Giovanni Canadé